
Villapianesi
Riflessioni antropologiche, lezioni didattiche e bagliori politici nella narrazione collettiva di una comunità in evoluzione. Esploriamo la storia villapianese, dai cambiamenti storici ai tratti culturali, per trarne insegnamenti utili e celebrare la nostra identità.
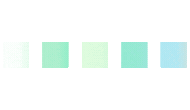
Premessa
La mia responsabilità riguarda la creazione di una pagina che si propone come una riflessione di carattere antropologico, didattico e politico sulla storia della comunità villapianese, focalizzandosi nei suoi momenti collettivamente più esaltanti o drammatici. L'intento è comprendere le motivazioni, le risposte, i tempi e le modalità di tali eventi, e trarne criticamente insegnamenti utili a prevenire errori e a garantire che alcuni aspetti positivi si trasformino in modus operandi definiti, anziché rimanere semplici manifestazioni umorali.
In conclusione, si mira ad analizzare, coinvolgendo attivamente i lettori, due peculiarità del comportamento del villapianese evidenzate nelle espressioni dialettali locali: a) il significato dell'accoglienza, rappresentato dalla frase "a saggète u ranche i mandre a curte"; e b) l'atteggiamento ambivalente del villapianese, caratterizzato negativamente da una propensione al conflitto e positivamente da una volontà combattiva contro ingiustizie e soprusi, come espresso nell'espressione "tenede u codice nda sacchette".
Il primo aspetto che affronterò dettagliatamente sarà la vicenda del cambiamento del nome da Casalnuovo a Villapiana, esplorando sia il suo contesto storico che la sua reinterpretazione da parte della popolazione attraverso una lente "novellistica". Successivamente, approfondirò altre vicende storiche e presenterò alcuni personaggi significativi, con l'obiettivo di offrire una panoramica completa e approfondita della storia della comunità villapianese.
News e Articoli

Il Ciabattino
Con lui tutto è diverso: egli è parola, gestualità, risata, circostanza, adattamento di ciò che dice agli eventi locali, in un pensiero finissimo, in cui tu non vedi cuciture e snodi, vedi la scarpa, elegante, luccicante, comoda, pieghevole nel suo cuoio di prima qualità, uscita dai suoi polpastrelli unicamente per te.
È il suo modo di pensare che non ha uguali, un intrigo di luci, ombre, odore salmastro di mare, verde tenerissimo di montagna, che non procede secondo una logica classica: una sequenza di considerazioni con una premessa, un corpo centrale, una conclusione e i riferimenti e accostamenti, nitidi e nei momenti opportuni.
Il suo è un pensiero che saltella, che è curioso e svia verso una stradina secondaria, ma se tu sai il suo intendimento e conosci le cose di riferimento, tu le capisci senza che egli nomini i punti di contatto e di rimando tra la microstoria locale e la grande storia. Le cose te le fa intuire, nel pudore di non nominare persone e fatti, per evitare che possa egli essere visto come uno che giudica o che dà a te la possibilità di emettere una sentenza. Gli altri, compresi i dotti, hanno un percorso lineare nel ragionamento, altri girano sempre su sé stessi, dopo magari delle premesse brillanti scadendo in conclusioni banali irretendo logica e intelligenza. Sono come il percorso che fa l’asino nel girare la macina nel mulino, passi identici e circolari e paraocchi, mai un sussulto, un volo di fantasia, una trasgressione o un’intuizione. O come avveniva nel passato ai ragazzini che giocavano con il rocchetto di legno, a cui era immesso dentro un elastico, che si caricava, girandolo più volte con un legno, che stava sopra un pezzo di sapone che serviva per far scorrere con regolarità il rocchetto; camminava sì, il cosiddetto carrarmato, con intacchi sul rocchetto per salire anche asperità, ma aveva sempre l’identica direzione.
Il suo, invece, parlo naturalmente del ciabattino, ribadisce la Piazza, è per fuochi d’artificio, per accostamenti che sembrano i meno prevedibili, ma che hanno una connessione profonda e sottesa, è ragionare, egli che amava solo la manualità (e questo è altro metro della sua mente particolare) come avviene nei social, dove si aprono più finestre, all’infinito. Lì forse ti perdi e non sempre cogli l’essenziale, con lui non avveniva.
Devo dire sinceramente, afferma decisa la piazza, che il mio modo di ragionare l’ho affinato proprio a contatto con lui. E poi, la varietà, la ricchezza emotiva e il godimento del suo narrare che diventa un teatro completo, fatto di sapienti silenzi, occhiate opportune, pause, differenti ritmi della risata, all’interno del dire, fino a quella ampia, liberatoria, omerica alla fine, con vibrazioni e accelerazioni del dire in connessione stretta con l’agilità dei suoi gesti, dei passettini, avanzare e retrocedere e poi sedersi spaparanzato sulla panchina o riprendere il suo viaggio tra me e casa sua per la strada dei ciucci.
Credimi, mi dice la piazza: è il giorno dopo il suo funerale, a volte penso che egli sia uno che sia nato in quei dieci giorni che la storia non registra, nel cambiamento del calendario giuliano a quello gregoriano, tra il 4 ottobre al 15 dello stesso mese del 1582 e quindi possa essere ovunque e sempre, in diverse possibilità di esistenza, in un’agilità come Proteo di incarnarsi, anche se noi ne abbiamo visto solo una delle sue tante maschere e modalità rappresentative, quella sua stazza imponente, il procedere quasi oscillante ma poi anche capace di estrema agilità nei passi con la stessa bellezza e maestria delle mani nel riparare e ricostruire scarpe o suonare la batteria con quel suo faccione bonario come una luna piena, i denti marci, il non arrabbiarsi mai anche quando qualche cretino lo infastidiva egli amava allontanarsi più che reagire.
Se non fosse così, non mi spiegherei, aggiunge la piazza, il fatto della particolarità della sua famiglia, ognuno, certo non al suo livello, tra il fantasioso e la stranezza al limite della marginalità e Peppino che forse avrebbe avuto più necessità di cure, attenzione, essere proprio lui a pensare anche alle incombenze e ai problemi materiali della famiglia, pensando a far provviste di vino, della legna, a fare la spesa, eccetera.
Forse il vento delle Conche che nello spirare dà molecole di fantasia e estrosità alla gente e a me naturalmente, ribadisce la piazza, per la nascita del ciabattino si è ingrossato in una tramontana alternata poi a scirocco per dargli tutte quelle modalità di vivere in tante difficoltà oggettive, che avrebbero abbrutito anche persone di cultura e normali: così egli ha svolto in leggerezza di spirito la sua missione di coscienza critica di un popolo, basandosi su principi basilari e sempre attuali: è volgare il sesso senza amore visto solo come godimento fisico, animalesco, è volgare il non impegnarsi nel lavoro per un progresso proprio e della collettività, è volgare arricchirsi violentando la natura e allontanarsi da essa. È volgare apparire e non curare l’essere, è volgare l’incultura che deriva da non sapere leggere criticamente un libro e il grande libro dell’esperienza; come volgare è non rispettare gli altri, la vita e creare problemi agli altri.
Non so se in questo suo esserci a Villapiana (in una delle sue tante possibili esistenze) sia stato l’incarnazione, per come ha esercitato il suo dialogo con la gente in piazza, del perdigiorno Socrate e Villapiana essere la sua lagnosa Santippe a volte.
Io penso di sì e a volte, in quel suo chinarsi per terra e con un gessetto scrivere su di me parole incomprensibili che poi diventavano colombe vibranti nel volo o cavalli pronti al galoppo, lo accostavo al Cristo incompreso quando difende dai farisei la prostituta. Egli nel suo essere diverso, ha dato dignità a tanti emarginati e persino la morte, datasi, violenta, tagliandosi la gola con la lesina e poi ad asciugarla del proprio sangue per non dare fastidio ai suoi, mentre cadeva morente a terra è un ribadire la vita, come Socrate nel bere la cicuta: la vita ha senso se il dialogo continua e non viene mortificato dalle istituzioni tiranne come per Socrate la sua Atene che si avviava alla tirannide o per il ciabattino dall’ambiente chiuso di Villapiana o della famiglia che quella sua diversità invece di vederla come l’unica estrinsecazione possibile della gioia di vivere la videro come una debolezza mentale, pericolosa e da curare, tanto da vietargli per mangiare forchetta e coltello.
Egli, dice mortificata la piazza, come fosse il suo dire il compianto ufficiale della sua dipartita: egli ha portato solo allegria e mai ha fatto male a qualcuno o detto una mala parola!
E così eventi e personaggi, smagriti, tisici, tristi, sopiti e stranamente anche inchiavettati nella loro magrezza come personaggi dell’inferno di Bruegel, nell’andare ampio del suo camminare dal grande fico sotto cui aveva battuto ore e ore il cuoio per ammorbidirlo e renderlo lucente e desideroso di viaggi ai piedi dei suoi compaesani, i viaggi più lunghi e meravigliosi, si animavano, si aprivano le borchie arrugginite della mente e della dimenticanza polverosa dove abitavano, e accesi dalla sua risata che aveva mille modulazioni, come la sua mente e il suo incedere, un esercizio musicale di potente orchestrazione, essi, eventi e personaggi uscivano smagriti dai loro peccati e acquistavano carne, pelle, forza, vigoria, brillantezza e il mastro ciabattino a dominarli con maestria nei loro andirivieni e nell’urgenza di farsi conoscere e a coordinarli, funzionalmente tra storia e microstoria così che il tentativo di costruire da parte di un terrorista locale una bomba senza una conoscenza degli attrezzi e intelligenza esecutiva nonché motivazione storica era lo scoppiargli tra le mani bruciandogli dita e volto: diventava l’esempio di chi in guerra, non conoscendo nemici e la loro posizione, sparava e non distruggeva l’avversario ma solo i bicchieri del vino in cantina in cui anime sciagurate vivevano piaceri volgari, debosciati e a casa fottendo solo per fare una nidiata di figli come conigli e senza un progetto di vita che ne sapesse organizzare tempi, modalità e futuro.
E nel tragitto da casa sua fino ad arrivare in piazza, la storia, dai Romani, da Orazio Coclite che si butta nel Tevere, taglia il ponte per sconfiggere i nemici fino a Moro che piange come na guagninella a chiedere l’intervento dello stato per essere liberato dalle brigate rosse, diversamente dalla fermezza di carattere di Gramsci, u bresce, l’albanese, con tanta gnognere, intelligenza in testa che non si piega a Mussolini, si animava come gemme, frutti succosi da cui trarre sapore e energia o, al contrario, diventare per nostra insipienza, marci e annacquati, che finanche i porci rifiutavano.
Così, tra i grandi eventi e i piccoli, quelli del paese, si instaurava, anche con una sottile ironia, un raccordo sotterraneo di confronto e valutazione, mischiando anche e stravolgendo creativamente mito e aneddoti storici: Garibaldi, eroe dei due mondi, che per essere presenti in entrambi gioca alla mucciatella, a mosca cieca e la donnetta che si vende va al Pireo per fare marchette, Teseo che mazzìa il minotauro per liberare il popolo, Ulisse che vince con l’astuzia Polifemo, Ercole che già nella culla uccide il serpente e invece il sarto che compra trenta lire di mortadella e non può fare certo un vestito ottimo perché senza mangiare la macchina umana, fisica e mentale, non è in grado di reggere alcun lavoro. Oppure parlava del mugnaio che non si vede mai in Piazza nemmeno a prendere un gelato, perché era preso dal sacrosanto furore del lavoro: in lui e altri come lui il ciabattino si riconosceva, purché non fosse un’attività truffaldina e fraudolenta, perché allora “la farina del diavolo va tutta in crusca”.
Il ciabattino, nella sua maestria creativa, sapeva trattare la materia nobile, il cuoio e anche quella vile e di poco conto, pur di fare delle scarpe decenti a chi aveva bisogno e ognuno, questo era il suo insegnamento “giunge dove può”, privilegiando dunque non l’intelligenza in sé, ma l’uso etico che se ne fa, per il proprio bene e quello della collettività.
E giunto finalmente in piazza “eh, eh, eh, bisogna uccidere i gattopardi, non si mettono pesci nel paniere, il comunismo non vince mai altrimenti eh, eh, eh” e così di seguito, in quell’inanellare, con arguzia, rimandi sotterranei e fantasiosi, fatti locali, personaggi che la gente conosce con eventi e personaggi distanti secoli da noi “Il gattopardo è un animale difficile da pescare hai mitte na picce suttu u pedalive e allora pu ncappisi. Ah, ah, ma jè difficile, nu cia fej. Quilli scappide e si futtude a picce. Ah, ah, ah e sa futtute aviti viste”.
Ogni tanto beve una birra fredda presa dal bar, si rinfresca quella bocca ampia e sdentata “ah, chi scialamenti si hanno fottuto tutto quello che i nostri padri hanno fatto. Hai visto u bresce, l’albanese. Dischetto, vuol dire che si mangia, la cultura è questo … il giorno aggiusta segge, sedie con il giunco e così campa … è stato in carcere e ora scrive le sue memorie, cosa mangiava pane formaggio acina … lavoro e senza andare sotto i ponti a fricare … zumpa zumpa cavalletta statti attindi che prima o poi zzinchisi, prendi u pisci i vrachetti, pesci della brachetta e dopo nascono i cunigli eehhhheeee. Essi non amano i piaceri volgari … Qua si fa l’Italia o si muore” dice alzandosi dalla panchina “gli tagliano una gamba e gli portano una rosa, ha fatto più danni di una guerra, senza lamentarsi e poi arrivano i colonnelli, mo sto aggiustando gli anfibi … è artiglieria pesante e ha giurato fedeltà allo stato, ma i politici rubano e si ne fregano del comandamento di dio non rubare e allora prendono Moro e lo maciullano con una scarica di mitra e scrive lettere e chiede perdono e loro continuano a mangiare si sono fregati na sirtère i pipirusse, corona intrecciata di peperoni essiccati e formaggio e i carabinieri non li nzicchini … U bresce ha gnognere nda capa, intelligenza in testa ha combattuto Mussolini, non ha chiesto grazie come na guaglinella, una ragazzina Moro era na femminella, questi albanesi son tosti, come nu curriuli, cintura di cuoio se ti stringono ti affocano … ci vuole l’applicazione delle scienze la fisica su nu calchisi, calcoli a traittoria del vento zicchisi u bicchiri prendi i bicchieri da cantina non i ladri della patria. Brigate rosse ... devi essere agile nello spirito come sanguette che succhia il sangue malamente e sa essere in equilibrio e azzicca i zichele e le farfalle … l‘arte è armonia e sentimento, altrimenti scivulisi, scivoli e ti fai come nu gliommirili e nno si capisce un cazzo … u bresce jè spirtu come il paradiso di Dante e Beatrice è il partito e lui accende la lampada, lume a petrolio e la sera ci vede …
Garibaldi, i due mondi, eheheh o era qua o era là, jucavdi alla mucciatella, giocava a nascondino a nascondino, entrando pu purtusu? (è un passaggio stretto del paese che congiunge la zona antica con la strada dei ciucci).
Le mie prigioni … una rosa e una spina na guagniella che sospira u ziti ma nu si fa tucchè e si spegne come cera e mai viene a compimento e … Moro, Moro dentro e fuori per l’angoscia e la vergogna, paradiso, purgatorio e inferno …
Michelangelo ha jettète, gettato na martellata alla statua: perché non parli? Leonardo, arte applicata per il primo volo. L’uomo colto va avanti, l’ignorante resta nella stalla.
Roma? Orazio Coclite, s’è jettète, gettato nel Tevere ha tagliète e corde e a rutte u ponte per vincere la guerra. Ah, ah.
"in una leggenda di Omero - Omero è stato il primo poeta che ha scritto leggende - si racconta del Minotauro che viveva in un Labirinto. Ogni anno a questo Minotauro bisognava dare in pasto una ragazza. Ora capitò che un anno venisse scelta Maria Grazia, la fidanzata di Perseo, Perseo s'incazzò moltissimo, prese una mazza e mazziò il Minotauro che se la prese nel culo. Dopo Perseo sposò Maria Grazia.
Il guerriero per riuscire nell'impresa si è dovuto fare un mazzo così.
Niente si ottiene per niente. Allora noi per ottenere qualcosa dobbiamo prendere la mazza e mazziare questi gattopardi-sceriffi-blasonati minotauri. Ah, ah, ah Ah, ah, ah, il comunismo non vince mai, non ne fate più liste. La gente vuole piaceri volgari … bisogna produrre. La bandiera italiana ha tre colori: il verde significa che devi seminare grano, e il bianco che devi avere la coscienza pulita. E il rosso? Ah, Ah, il rosso, mazzate! … andate a lavorare, vagabondi”
A concludere, poi, l’omaggio a Dante e implicitamente alla piazza che sente sua e che porta il nome del sommo poeta.
Dante? Ah, ah, ah, fa facendo due saltelli e ridendo negli occhi: il poema cui hanno posto mano cielo e terra. Fissjide. Hai visto chi nasc’ca? grande intelligenza, aveva fiuto, raste e seguiva passo passo inferno purgatorio e paradiso fino a rivedere le stelle. Ah, ah, i cusividi cu curiule le parole e restavano appiccichete a brillare, lavète e poi asciutte … le stelle nella sua fantasia. Chi rintaglie, na lisca e na pinta i parole. Pu chiuppidi nella spirtininzia granne. La sua fantasia. Jè jlle che cuside, quale Apollo, inventa canzone e cosucuselle picunijde fino a che a fimmine ci credide, s’ncantade e frichide … narramète u cintu e cu ha invintete, da tanne fino a mò je rimaste nda na rese … Dante, padre della patria, un gigante, jè jlle che ha scritto, ti fa vide a scena, tocchisi ccu i mène l’acqua conobbi il tremolar della marina … Vuvulijde, vullude l’acque come catacatasce che si appiccichine … ah, ah, che uomo, chi nasc’ca.
La risata esplode ampia e improvvisa come il barattolo che da ragazzi si poneva su una buca, riempita da carburo, facendolo saltare, coll'accendere la miccia a distanza, con una canna, più di venti metri in aria, da incoscienti, per il pericolo reale di sfregiarsi viso e mani.
Egli resta forse l’ultimo pensatore in un tempo assetato, capace, nella sua andatura, sia di dare a ogni singola cosa un ritmo solitario e lento, sia di farlo essere arditamente un fulmine che solca l’aria e elettrizza mente e corpo.
Così la piazza riporta alcuni aspetti, non tutti, della ricostruzione storica del ciabattino. Altri detti, memorabili, restano nell’alito del vento delle Conche, nella memoria della piazza per dilettare altre menti e insegnare a generazioni future.
Quel giorno l’aria era ferma, sospesa, in attesa.
Ma il fico di Peppino dove egli lavorava ad aggiustare scarpe generava mormori e un venticello fresco, tra sospiri e sogni.
Come se quel luogo fosse, segretamente, germinativo di vento e di ciò che esso significava per la piazza e la comunità di Villapiana, alla stessa stregua delle Conche.
La ricostruzione storica della civiltà da parte del ciabattino.
Da: Gianni Mazzei - Come il vento dalle Conche. Terra d’Ulivi, Lecce 2022.
InCanto nel Borgo
Benvenuti nell'incantevole mondo di "InCanto nel Borgo", i creatori e protagonisti di questo capolavoro hanno sapientemente utilizzato il canto lirico, interpretato con maestria da Maria Addolorata Mondella, per narrare il sogno e l'infanzia di Villapiana. Attraverso la brillante ambientazione nel centro storico e l'uso simbolico di elementi come le porte aperte e le scalinate, il video racconta la storia di una comunità che si riscopre attraverso la musica e la tradizione. Gli abiti straordinari ideati da Bevilacqua e la regia di Federico contribuiscono a enfatizzare la componente lirica e narrativa del video. Un plauso agli artisti e a chi si impegna per il bene morale, culturale e civico di Villapiana. Scopriamo insieme questo viaggio emozionante nel cuore della creatività e della tradizione, nell'articolo completo anche la galleria foto dell'evento.

Tabasciajà
(racconto villapianese, in omaggio a Giuseppe Lippolis che me l'ha raccontato)
Sarà successo in un pomeriggio di febbraio considerato dai contadini il mese “curtu e amère”, per gli improvvisi freddi che giungono e seccano tutto; ma ha anche una propria dolcezza, non solo per quei tiepidi momenti in cui l’aria quasi ha l'avvisaglia di primavera e trema il mandorlo di piacere a germogliare, quasi con stupore. Ma anche perché i cani, chissà perché, vanno in calore proprio in questo periodo ed è allora un correre, un ululare di essi per le strade del paese e tu senti oltre il respiro persino quell’odore delle cagne che fa impazzire i maschi. Il Comune pensava di poter risolvere il problema, nominando degli accalappiacani; invano, bastava che ne arrivassero due o tre dalla campagna, specie quei maremmani che a volte riuscivano, chiamati dall’istinto, a fuggire dai recinti delle pecore che proteggevano al pascolo, che era un fuggi fuggi generale per le vie del paese da parte degli abitanti, tanti erano feroci e pericolosi i cani, grossi come piccoli vitelli e con quei collari chiodati al collo, irti e appuntiti che servivano a difenderli dai lupi.
al pascolo, che era un fuggi fuggi Stranamente, quel giorno alle 15, la piazza era vuota, da poco era passato il pullman che da Plataci scende alla Marina di Villapiana e ancora i bar erano chiusi, riaprendo essi di solito verso le 16, quando la gente scappa dal lavoro e i contadini arrivano dalla campagna con gli asini carichi e li si porta ad abbeverare alla fontana posta al centro della piazza. Egli, Tabasciajà, era coricato sul muretto dell’abitazione del dottor Sisci, quasi dormiva, in quel suo mantello da pastore: usciva fuori solo il viso, una pelle dura come la carta vetrata, resa così dalle malattie dell’Abissinia dove per anni era stato sotto le armi, durante il ventennio fascista e a guerra finita si diceva esserci rimasto, preso da quelle cosce frementi delle Abissine, da cui aveva avuto, si diceva, anche dei figli, disinteressandosi così per molto tempo della famiglia che aveva a Villapiana, che lo considerava morto, visto che per molto tempo non aveva dato notizie di sé. Per cui, quando tornò, la moglie non l’accettò e gli disse irata, mandandolo a dormire in una casupola, prima adibita a canile “dove hai fatti lluve, vai a ffè pure i cachinazzi”. Si arrangiava per vivere facendo qualche giornata e contando sul buon cuore della gente del vicinato che ogni tanto gli portava un piatto di minestra calda “pa more i Gisù Cristu”.
Parlava poco e con frasi smozzate, quasi monosillabi, miste tra dialetto e espressioni arabe, almeno nella cadenza cantilenante. Aveva acquistato un suo prestigio, quasi un rispetto, quando, in una manifestazione di un sabato di regime, al grido del segretario del fascio a cui si doveva rispondere nella stessa maniera “Alalala” per osannare il duce, egli, forse, svagato in testa o per qualche bicchiere di vino, aveva gridato “Alla larga” ed era stato messo in prigione per qualche giorno, come se avesse offeso Mussolini, diventando, suo malgrado, un analfabeta e uno straccione, l’espressione più alta dell’antifascismo in tutto l’alto jonio cosentino. Ma la sua vera gloria, quella che ne aveva fatto un personaggio, quasi un mito, spesso imitato da tutti, ma con esiti disastrosi, come proprio quella mattina, ultimo da Francesco, capelli lunghi e barba fluente da profeta, qualche espressione della bibbia imparata a memoria, per darsi un’aria, che mandava in bestia il prete del luogo, era un’altra: mangiare vetro, ferro filato, per scommessa, o qualche dieci lire o una bevuta gratis, diventando alla fine, come tutti i poveri cristi che vivono di espedienti per campare, un fenomeno da baraccone, con cui trastullarsi. Se gli offrivi un bicchiere di cognac nel bar, egli riusciva, dopo aver bevuto, a triturare in finissime parti il vetro e a mangiarlo, senza tagliarsi la lingua e senza avere altri problemi: diversamente da Francesco, come si diceva, che quella mattina, nel bar del Barone, volendo fare lo spaccone e invocando il suo Dio, appena cominciò a triturare il vetro s’insanguinò tutto e venne portato d’urgenza in ospedale, più morto che vivo.
Alcune brevi considerazioni sui Soprannomi dei Villapianesi
Si è già detto che la grammatica del dialetto villapianese è mutuata dalla lingua latina. Qualcosa di simile avviene per i soprannomi, nel rapporto tra nomen (che è nel dialetto il cognome) e il cognomen (che diventa il soprannome, per indicare un ceppo familiare). I soprannomi indicano, in realtà, generalmente un‘intera famiglia, raramente il singolo.
C’è da dire, però, ad indicare la vivacità della lingua che ancora esiste la capacità, da parte della comunità villapianese, di inventare, in modo colorito ed adeguato, soprannomi per le singole persone. Ciò sta ad indicare anche il senso dello stare insieme, del non estraniarsi, come avviene nelle città, il senso gioioso e di ironica partecipazione alla vita della collettività. Il soprannome per il singolo generalmente è recente.
Francischi i Vurpi
Cosa avesse di “volpino”, lui che era l’ingenuità in persona, non si è mai capito: forse la mansuetudine dello sguardo, quando il cacciatore stana la volpe e sta per ammazzarla e lei spera che possa sfuggire al suo tragico destino. Lo si vedeva per le vie del paese, col suo abituccio sdrucito, color grigio, ma dignitoso, camminare a testa bassa che ogni tanto alzava, incontrando le persone, per ripetere con quella voce stranamente gutturale in quel corpo gracile.” Anò, anò”. Che cosa veramente significasse questo intercalare che aveva la nostalgia di una nenia antica, non si è mai chiarito: un misto tra dimmi, senti, per attirare l’attenzione ed essere considerato uguale agli altri. Non aveva nessuno Francischi i Vurpi se non il paese: e per il paese egli era l’ambasciatore celere per ogni incombenza. Se nella farmacia mancava qualche medicina, chi ne aveva bisogno lo comandava per recarsi nella vicina …, paese più grande e attrezzato, per andarla a prendere.




